Descrizione
Recensione di Guglielmo Piombini
Il crollo delle nazioni di Leopold Kohr, pubblicato nel 1957 con il titolo The Breakdown of Nations e tradotto in italiano nel 1960, costituisce una straordinaria riflessione sulle ragioni universali della superiorità dei sistemi fondati sulle piccole unità piuttosto che sulle grandi. Leopold Kohr utilizza una grandissima quantità di argomenti filosofici, scientifici, storici, politici, economici e sociologici per dimostrare come un sistema basato sull’equilibrio di tanti piccoli staterelli possa garantire, molto più che un sistema basato su poche grandi potenze, la pace, la sicurezza, nonché la fioritura culturale ed economica.
Purtroppo il libro, quando uscì verso la fine degli anni Cinquanta, venne quasi completamente ignorato perché le idee prevalenti andavano nella direzione opposta. In quegli anni il mondo era diviso in due blocchi dominati da due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Urss, e da ogni parte si esaltavano la centralizzazione, la programmazione dall’alto, la creazione di grandi entità sovranazionali. Il gigantismo politico ed economico, non certo l’apprezzamento per le dimensioni ridotte, costituiva la passione dell’epoca. Le idee del professor Leopold Kohr, americano di origine austriaca, vennero quindi rigettate dalla cultura dominante, ed egli dovette accontentarsi di una posizione accademica di secondo piano presso l’università di Portorico. Solo dopo la fine della guerra fredda le sue idee sono state riscoperte, grazie al generale risveglio delle piccole patrie e dei sentimenti indipendentisti in Europa e nel mondo.
Il problema universale delle grandi dimensioni
Al cuore della riflessione di Leopold Kohr vi è la teoria delle dimensioni, secondo cui la causa di quasi tutte le miserie sociali è una sola: la grandezza. Per Kohr il raggiungimento di dimensioni eccessive non rappresenta uno dei tanti problemi sociali, ma è l’origine di ogni problema dell’universo. Ad esempio, le stelle esplodono quando raggiungono una dimensione eccessiva perché hanno superato i limiti invalicabili dell’espansione della materia; il corpo umano si ammala di cancro perché un gruppo di cellule ha cominciato a svilupparsi oltre i limiti fissati dalla natura; analogamente, se un organismo sociale si lascia prendere dalla febbre dell’aggressività, della brutalità o da una follia collettiva, spiega Kohr, «ciò avviene non perché esso sia caduto sotto un cattivo governo o sia colpito da aberrazione mentale, ma perché gli individui – che sono così amabili se presi uno ad uno o in piccoli gruppi – si sono fusi in unità sociali eccessivamente vaste, come le masse proletarie, i grandi sindacati, i cartelli, o le grandi potenze, incominciando quindi a scivolare lentamente verso un’inevitabile catastrofe» (p. 10).
Se una società supera le dimensioni che più le si addicono, i suoi problemi finiscono per moltiplicarsi con una rapidità maggiore della capacità umana di affrontarli. Oltre una certa dimensione i problemi sociali diventano assolutamente ingestibili e irrisolvibili. L’unica soluzione, per lo studioso austro-americano, è quindi quella di ridurre i problemi a una grandezza accettabile, rimpicciolendo gli organismi che, sviluppandosi, hanno superato i loro limiti naturali. Non bisogna creare unità sociali ancora più vaste e governi ancora più potenti, come auspica la grande maggioranza degli uomini politici e degli scienziati sociali, ma piuttosto eliminare quegli organismi sovrasviluppati chiamati “grandi potenze” e restaurare un sano sistema di piccoli Stati facilmente controllabili, come quelli che hanno caratterizzato certe epoche passate.
L’aggressività nasce dal potere
Le guerre, spiega Kohr, sono sempre causate da un eccesso di grandezza o di potenza. Quando il potere raggiunge una certa misura critica, sentendosi al sicuro da ogni forma di ritorsione, degenera sempre nell’abuso, nella violenza e nella brutalità. Esiste pertanto una legge invariabile e universale secondo cui il pericolo di aggressioni si manifesta inevitabilmente tutte le volte in cui il potere di uno Stato diventa così grande da superare, nella valutazione di chi governa, quello delle forze avversarie. Uno Stato diventa automaticamente aggressivo quando fa sorgere in chi lo gestisce la convinzione di non poter essere minacciato dall’esistenza di altre più vaste accumulazioni di potere. La religione, l’ideologia, la razza o la cultura sono irrilevanti; quello che conta è solo la nuda materialità della massa del potere.
La storia lo conferma. Oggi non si conoscono popoli più miti dei degli svedesi, dei norvegesi e dei danesi, ma nel Medioevo i vichinghi e i normanni, quando erano forti e potenti, si dedicarono con furore ai saccheggi e alle conquiste. I portoghesi e gli olandesi erano pacifici in Europa, ma aggressivi nelle colonie dove il loro potere raggiungeva un livello critico nei confronti delle popolazioni indigene. L’Italia, il Giappone e la Germania sono diventate aggressive solo quando si sono trovate improvvisamente a disporre di un grande potere. Lo stesso popolo che invase l’intera Europa coi terribili eserciti di Hitler costituì una delle più inoffensive società umane fintanto che restò diviso in piccoli principati indipendenti: se si fossero sottratti al movimento unificatore promosso da Bismarck e alla concentrazione di potere che ne derivò, sarebbero rimasti pacifici anche durante le due guerre mondiali, proprio come gli abitanti di etnia tedesca del Liechtenstein e della Svizzera. Anche gli Stati Uniti d’America all’inizio erano isolazionisti, ma si sono trasformati in un impero globale quanto più il potere si concentrava nel governo federale di Washington.
I pericoli delle unificazioni
Se vogliamo liberare il mondo da minacce di guerre aggressive, osserva Kohr, l’errore più grave è quello di favorire le unificazioni politiche. In questo modo, infatti, non faremo altro che aumentare il terrificante potenziale che si sprigiona dai grandi organismi. Infatti quasi tutte le guerre sono state combattute in nome dell’unificazione, che viene sempre presentata come una pacificazione. La guerra più terribile degli Stati Uniti, quella di secessione, fu combattuta per preservare l’unità del paese. In Europa l’unificazione ha offerto spesso il pretesto a un grande Stato di annettersi uno più piccolo: «Sicché si arriva al paradosso che quasi tutte le guerre sono state combattute in nome dell’unità e della pace, il che significa che, se non fossimo stati unionisti e pacifisti tanto accaniti, avremmo potuto evitare un buon numero di conflitti» (p. 123).
Il metodo per ridurre l’aggressività delle società umane è dunque quello, esattamente opposto, della divisione delle unità politiche troppo grandi. La Svizzera, ad esempio, ha sempre risolto pacificamente i propri dissidi interni con il metodo della separazione, suddividendo ulteriormente un cantone. Anche l’Europa dovrebbe prendere questo esempio, smembrando gli Stati nazionali in una moltitudine di piccole patrie corrispondenti alle attuali regioni o province. Eliminando le strutture artificiali delle grandi potenze, la carta d’Europa tornerebbe alla sua naturale conformazione. Secoli di convivenza forzata e di propaganda patriottica non hanno potuto infatti sradicare i sentimenti localistici e lo spirito di autonomia.
Ma non si verrebbe in questo modo a creare un mondo simile a quello medievale, durante il quale le piccole entità politiche combattevano tra loro senza sosta? In realtà le “guerre” che nel Medio Evo divampavano in ogni angolo d’Europa erano dei piccoli conflitti localizzati che duravano pochi giorni, e che spesso si concludevano senza vittime. Avevano conseguenze trascurabili perché le entità che le combattevano erano piccole e dotate di modeste risorse. A seguito delle unificazioni nazionali le guerre si verificano a intervalli più lunghi rispetto alle guerre medievali, ma hanno conseguenze molto più serie. Si hanno più prolungati periodi di pace, ma quando alla fine esplodono le guerre trascinano nel loro vortice una gran parte del mondo. Un solo mese di guerra moderna tra grandi potenze costa più, in vite umane e in beni, di quanto potessero costare secoli e secoli di guerre medioevali.
La libertà nei piccoli Stati
In un piccolo Stato gli individui sono più liberi perché non sentono soggezione nei confronti di chi governa e non possono essere sopraffatti dal potere. I governanti di un piccolo Stato sono, per così dire, i vicini di casa del cittadino. Tutti li conoscono personalmente, e perciò non potranno mai celarsi sotto quelle spoglie misteriose che permettono di assumere l’aria distaccata e severa di superuomini. I più grandi tiranni del mondo, come Cesare, Napoleone, Hitler o Stalin, sono sorti in grandi Stati, mentre in un piccolo Stato un dittatore sembra un ridicolo personaggio da operetta, e non fa paura a nessuno.
Anche la rappresentanza politica perde significato in un grande Stato, dove i cittadini rappresentano una parte infinitesimale della sovranità. Infatti, più l’aggregato sociale aumenta di proporzioni, più l’uomo diventa insignificante. In uno Stato vasto e popoloso l’individuo non ha alcuna possibilità di opporsi alla straripante potenza di un movimento di massa che, alla fine, è destinato a travolgerlo. Egli assorbirà la fede collettiva del grande gruppo organizzato, come il militarismo, il nazionalismo, il socialismo o il comunismo, e perderà la coscienza in un autonomo significato della sua vita.
Dove nasce il progresso culturale
I grandi Stati impressionano solo per la loro potenza materiale, e vengono ammirati in un mondo che stima più la forza fisica che i valori intellettuali. Lo spirito individuale, infatti, può affinarsi soltanto quando vive nel tranquillo e libero rifugio della piccola società, al riparo dalle grandi masse. Perciò non si deve attribuire a pura coincidenza il fatto che la cultura mondiale si sia sviluppata soprattutto in piccoli Stati. Tutti i grandi imperi dell’antichità non sono stati capaci, nei millenni della loro esistenza, di produrre dal punto di vista culturale nemmeno una minima parte di quello che è stato prodotto in alcuni decenni dalle piccole città-stato della Grecia.
Quando l’Italia era divisa in tante piccole entità politiche diede al mondo uomini come Dante, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tasso e centinaia di altri, il meno importante dei quali sembra più grande del più notevole artista dell’Italia moderna, chiunque possa essere. Anche la Germania divisa in tantissime piccole corti reali produsse geni come Goethe, Wagner, Kant, Dürer, Holbein, Beethoven, Bach e centinaia di altri. Che cosa ci hanno dato le stesse regioni una volta divenute grandi potenze? Sono passate da raffinate forme di civiltà a un barbaro spirito di aggressione, producendo una masnada di uomini politici e militari senza immaginazione, come Hitler o Mussolini.
Vi sono ragioni precise per cui l’arte non può fiorire nell’aria irrespirabile delle grandi potenze. Innanzitutto i governanti dei piccoli Stati, non avendo eserciti potenti, possono sfogare la propria ambizione nei più pacifici campi dell’arte e della cultura. In Italia e in Germania il mecenatismo fu infatti il risultato della forte rivalità esistente tra la miriade di corti e principati. Ogni impresa artistica realizzata da uno di essi suscitava negli altri un fiero sentimento di gelosia e quindi nuovi tentativi di emulazione, generando una creazione artistica senza soste.
Grazie a questo processo oggi noi possiamo ammirare una sorprendente varietà di tendenze artistiche e architettoniche, ben diverse dalla monotonia e dallo scialbore delle gigantesche opere dovute ai ciclopici organismi politici successivi. Se in parecchi Stati europei di grande estensione, come l’Italia, la Francia o la Germania, è ancora possibile, con viaggi relativamente brevi, fare esperienza di tante interessanti differenze culturali, ciò è dovuto al fatto che il pluralismo politico medievale ha lasciato un’impronta così duratura che neppure il processo di unificazione ha potuto cancellarla. Oggi, osserva Kohr, i turisti accorrono per godersi le bellezze create non dagli Stati nazionali ma dai loro piccoli e “arretrati” predecessori.
Inoltre, grazie alla limitata importanza che hanno i problemi sociali nei piccoli Stati, i cittadini si trovano nelle condizioni migliori per coltivare l’arte e la cultura. Le grandi creazione della mente umana, infatti, non sono favorite dalla partecipazione alla vita politica, ma al contrario si giovano dall’allontanamento da essa. Nei piccoli Stati non c’è bisogno di enormi apparati di governo e di controllo, per cui la maggior parte dei cittadini può dedicarsi al miglioramento dell’individuo anziché al servizio dello Stato. Le esigenze sociali delle grandi potenze, al contrario, sono tali da assorbire tutte le energie disponibili non solo dei funzionari di Stato, ma anche dei cittadini. Negli Stati nazionali gli artisti, i poeti, i letterati e i musicisti sono progressivamente sostituiti da specialisti, tecnici, organizzatori ed esperti di problemi sociali.
Grandi Stati, grandi problemi
In un mondo di grandi Stati, osserva Kohr, siamo continuamente assillati da giganteschi problemi sui quali non abbiamo nessuna possibilità di influire e che ci rovinano la vita. In un mondo come il nostro “ogni dannata questione è diventata un problema per tutti”. In un sistema di piccoli Stati, invece, le numerose frontiere fanno da elementi isolanti, e i problemi delle regioni lontane restano problemi remoti. Invece di doverci occupare di calamità universali, permanenti e impersonali, ci ritroviamo in una realtà ristretta in cui siamo protagonisti. In questo piccolo ambiente tutto fa parte della nostra esperienza personale, e i problemi non avranno carattere anonimo, ma ci toccheranno da vicino. Non esiste grave problema sulla terra che non possa essere felicemente risolto su scala ridotta, mentre su vasta scala tutti i problemi diventano incomprensibili e spaventosi, dato che non esiste intelligenza umana capace di gestirli.
Contrastando la mania suicida delle unificazioni politiche nazionali o sovranazionali, Kohr propone di smembrare tutte le attuali grandi potenze all’interno di federazioni composte da tante unità di grandezza simile. Ad esempio, si potrebbe creare un Consiglio Europeo senza Stati nazionali, in cui ogni provincia della Francia, della Germania, dell’Inghilterra, dell’Italia, della Spagna e di tutti gli altri paesi abbia diritto a un voto. In questo modo le attuali nazioni più grandi conserverebbero un maggior numero di voti. “Ma sarà fatto?”. La risposta si trova nel brevissimo undicesimo capitolo, che è composto da una sola parola: No!
Anche se l’autore non si illude sulla disponibilità delle grandi nazioni a farsi polverizzare, egli è tuttavia persuaso che tutti i potenti Stati e imperi sono prima o poi destinati a crollare sotto il proprio peso. La storia, scrive Kohr, si ripeterà, e le epoche di sterilità intellettuale segnate dal dominio delle grandi potenze lasceranno il posto alla grandezza culturale che ha caratterizzato i mondi piccoli e liberi del passato, come quelli del Medio Evo o dell’Antica Grecia.
Citazioni rilevanti
La causa della guerra
«E anche in questo caso vedremo come la causa di un terribile evento come la guerra non debba essere attribuita a diabolici disegni o a perfide inclinazioni, ma all’esistenza di un potere eccessivo in mano a società troppo vaste. Il fatto è che ogniqualvolta uno Stato diventa grande abbastanza per accumulare la massa critica di potere, prima o poi cederà alla tentazione. E appena tale potere sarà nelle sue mani, diventerà uno Stato aggressore, nonostante il suo passato e le buone intenzioni» (p. 80).
I grandi Stati sono totalitari per natura
«Per quale motivo gli uomini non dovrebbero avere tanti sistemi quanti essi ne desiderano, invece di dover adattarsi tutti allo stesso quando la metà non lo considera di proprio gusto? Se la libertà di scelta è considerata un vantaggio dal punto di vista economico, perché non dovrebbe esserlo dal punto di vista politico?» (p. 145)
I cattivi maestri centralisti
«Non riuscendo a sottrarsi al fascino di un grande potere, il quale, pur essendo contro ogni regola di buon senso, esercita una forte attrattiva psicologica, essi scagliano i loro feroci strali contro tutto ciò che è piccolo, innalzando all’onore degli altari tutto ciò che rappresenta grandezza, volume, massa. Essi ci hanno persuaso a venerare il colossale e poi si sono stupiti che noi ci inchinassimo a Hitler che impersonava proprio questo ideale di grandezza» (p. 218-219).
Le degenerazione culturale di italiani e tedeschi
«Fin dal loro sorgere come grande potenza nel 1871, gli Italiani, nel complesso, non hanno più desiderato di farsi conoscere come artisti ma come padroni, non come pacifici agnellini, ma come conquistatori, non come Fiorentini ma come Romani. Il potere li ha trasformati in Prussiani, come è avvenuto dei Prussiani stessi, e il passo romano, che Mussolini non a caso introdusse nel suo esercito, corrisponde esattamente alla mentalità che si era venuta creando in Italia dopo il 1871, come è vero che la gentilezza, la sensibilità artistica, la grazia e la delicatezza non erano affatto estranei alla mentalità tedesca prima di tale data, cioè quando la Germania era ancora in gran parte divisa in un complesso di piccoli Stati» (p. 249).
Gli inevitabili sperperi delle grandi potenze
«Più una società diventa potente, più aumenta la parte della sua produzione che, invece di accrescere i consumi individuali, viene assorbita dalla necessità di risolvere i problemi causati dal sorgere del suo grande potere … Esempi della prima categoria di questi beni “di sviluppo” che elevano il livello della società senza aggiungere nella al benessere materiale dei suoi membri, sono quelli che potrebbero essere chiamati i vantaggi del potere, come i carri armati, le bombe, o il perfezionamento dei servizi pubblici necessari per amministrare un’accresciuta potenza» (p. 281).
I fanatici delle unificazioni
«In Europa i sentimenti particolaristici, malgrado siano stati per lungo tempo soffocati dai grandi Stati unitari e sottoposti all’incessante martellamento di una propaganda a favore dell’unificazione, ancora esistono conservando immutato il loro vigore, e ben poche delle piccole e numerose nazioni d’Europa, ora unite insieme nell’ambito di grandi potenze, potrebbero essere lasciate in libertà per una sola settimana senza correre il rischio di vederle subito all’opera per rivendicare una propria sovranità, e un parlamento e una capitale propria. Naturalmente esistono individui – come i maestri elementari, i nazionalisti, i militari, i collettivisti, i maniaci dell’umanità, ed altri che in costruzioni unitarie trovano un motivo di esaltazione, i quali tutti, con cieco fanatismo e con reazionaria violenza, si oppongono al concetto dei piccoli Stati democratici» (p. 368-369).
L’autore
Leopold Kohr (1909-1994) nasce nella piccola città di Oberndorf bei Salzberg, in Austria, che rimane per sempre nella sua mente come il tipo ideale di comunità. Consegue il dottorato in legge presso l’Università di Innsbruck e in Scienze politiche presso l’Università di Vienna. Studia poi economia e teoria politica presso la London School of Economics. Nel 1937, durante la guerra civile spagnola, diviene corrispondente free-lance, e rimane profondamente colpito dagli esperimenti anarchici nelle città di Alcoy e di Caspe. In quel periodo diventa amico e si trova a lavorare con George Orwell, Ernest Hemingway, André Malraux. Nel 1938, fugge dall’Austria dopo l’annessione alla Germania nazista, ed emigra negli Stati Uniti dove prende la cittadinanza. Dal 1943 al 1955 Kohr insegna economia e filosofia politica nel New Jersey presso la Rutgers University, mentre dal 1955 al 1973 insegna Economia e della Pubblica amministrazione presso l’Università di Puerto Rico. Dopo molti rifiuti ricevuti, da parte di editori americani e inglesi, nel 1957 riesce a pubblicare in Gran Bretagna The Breakdown of Nations, grazie all’aiuto dell’anarchico britannico Herbert Read. Nel 1973 si trasferisce nel Galles, e svolge attività di sostegno al movimento di indipendenza gallese. Qui insegna filosofia politica presso l’Aberystwyth University. Dopo il ritiro dall’attività didattica Kohr divise il suo tempo tra Gloucester e Hellbrunn, nei pressi di Salisburgo. Muore a Gloucester il 26 febbraio 1994, e viene sepolto nel suo paese natale di Oberndorf.



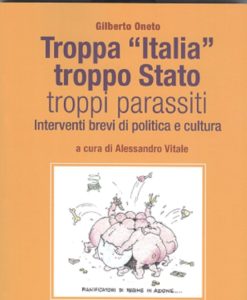


Libreria del Ponte –
Recensione di Guglielmo Piombini
Il crollo delle nazioni di Leopold Kohr, pubblicato nel 1957 con il titolo The Breakdown of Nations e tradotto in italiano nel 1960, costituisce una straordinaria riflessione sulle ragioni universali della superiorità dei sistemi fondati sulle piccole unità piuttosto che sulle grandi. Leopold Kohr utilizza una grandissima quantità di argomenti filosofici, scientifici, storici, politici, economici e sociologici per dimostrare come un sistema basato sull’equilibrio di tanti piccoli staterelli possa garantire, molto più che un sistema basato su poche grandi potenze, la pace, la sicurezza, nonché la fioritura culturale ed economica.
Purtroppo il libro, quando uscì verso la fine degli anni Cinquanta, venne quasi completamente ignorato perché le idee prevalenti andavano nella direzione opposta. In quegli anni il mondo era diviso in due blocchi dominati da due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Urss, e da ogni parte si esaltavano la centralizzazione, la programmazione dall’alto, la creazione di grandi entità sovranazionali. Il gigantismo politico ed economico, non certo l’apprezzamento per le dimensioni ridotte, costituiva la passione dell’epoca. Le idee del professor Leopold Kohr, americano di origine austriaca, vennero quindi rigettate dalla cultura dominante, ed egli dovette accontentarsi di una posizione accademica di secondo piano presso l’università di Portorico. Solo dopo la fine della guerra fredda le sue idee sono state riscoperte, grazie al generale risveglio delle piccole patrie e dei sentimenti indipendentisti in Europa e nel mondo.
Il problema universale delle grandi dimensioni
Al cuore della riflessione di Leopold Kohr vi è la teoria delle dimensioni, secondo cui la causa di quasi tutte le miserie sociali è una sola: la grandezza. Per Kohr il raggiungimento di dimensioni eccessive non rappresenta uno dei tanti problemi sociali, ma è l’origine di ogni problema dell’universo. Ad esempio, le stelle esplodono quando raggiungono una dimensione eccessiva perché hanno superato i limiti invalicabili dell’espansione della materia; il corpo umano si ammala di cancro perché un gruppo di cellule ha cominciato a svilupparsi oltre i limiti fissati dalla natura; analogamente, se un organismo sociale si lascia prendere dalla febbre dell’aggressività, della brutalità o da una follia collettiva, spiega Kohr, «ciò avviene non perché esso sia caduto sotto un cattivo governo o sia colpito da aberrazione mentale, ma perché gli individui – che sono così amabili se presi uno ad uno o in piccoli gruppi – si sono fusi in unità sociali eccessivamente vaste, come le masse proletarie, i grandi sindacati, i cartelli, o le grandi potenze, incominciando quindi a scivolare lentamente verso un’inevitabile catastrofe» (p. 10).
Se una società supera le dimensioni che più le si addicono, i suoi problemi finiscono per moltiplicarsi con una rapidità maggiore della capacità umana di affrontarli. Oltre una certa dimensione i problemi sociali diventano assolutamente ingestibili e irrisolvibili. L’unica soluzione, per lo studioso austro-americano, è quindi quella di ridurre i problemi a una grandezza accettabile, rimpicciolendo gli organismi che, sviluppandosi, hanno superato i loro limiti naturali. Non bisogna creare unità sociali ancora più vaste e governi ancora più potenti, come auspica la grande maggioranza degli uomini politici e degli scienziati sociali, ma piuttosto eliminare quegli organismi sovrasviluppati chiamati “grandi potenze” e restaurare un sano sistema di piccoli Stati facilmente controllabili, come quelli che hanno caratterizzato certe epoche passate.
L’aggressività nasce dal potere
Le guerre, spiega Kohr, sono sempre causate da un eccesso di grandezza o di potenza. Quando il potere raggiunge una certa misura critica, sentendosi al sicuro da ogni forma di ritorsione, degenera sempre nell’abuso, nella violenza e nella brutalità. Esiste pertanto una legge invariabile e universale secondo cui il pericolo di aggressioni si manifesta inevitabilmente tutte le volte in cui il potere di uno Stato diventa così grande da superare, nella valutazione di chi governa, quello delle forze avversarie. Uno Stato diventa automaticamente aggressivo quando fa sorgere in chi lo gestisce la convinzione di non poter essere minacciato dall’esistenza di altre più vaste accumulazioni di potere. La religione, l’ideologia, la razza o la cultura sono irrilevanti; quello che conta è solo la nuda materialità della massa del potere.
La storia lo conferma. Oggi non si conoscono popoli più miti dei degli svedesi, dei norvegesi e dei danesi, ma nel Medioevo i vichinghi e i normanni, quando erano forti e potenti, si dedicarono con furore ai saccheggi e alle conquiste. I portoghesi e gli olandesi erano pacifici in Europa, ma aggressivi nelle colonie dove il loro potere raggiungeva un livello critico nei confronti delle popolazioni indigene. L’Italia, il Giappone e la Germania sono diventate aggressive solo quando si sono trovate improvvisamente a disporre di un grande potere. Lo stesso popolo che invase l’intera Europa coi terribili eserciti di Hitler costituì una delle più inoffensive società umane fintanto che restò diviso in piccoli principati indipendenti: se si fossero sottratti al movimento unificatore promosso da Bismarck e alla concentrazione di potere che ne derivò, sarebbero rimasti pacifici anche durante le due guerre mondiali, proprio come gli abitanti di etnia tedesca del Liechtenstein e della Svizzera. Anche gli Stati Uniti d’America all’inizio erano isolazionisti, ma si sono trasformati in un impero globale quanto più il potere si concentrava nel governo federale di Washington.
I pericoli delle unificazioni
Se vogliamo liberare il mondo da minacce di guerre aggressive, osserva Kohr, l’errore più grave è quello di favorire le unificazioni politiche. In questo modo, infatti, non faremo altro che aumentare il terrificante potenziale che si sprigiona dai grandi organismi. Infatti quasi tutte le guerre sono state combattute in nome dell’unificazione, che viene sempre presentata come una pacificazione. La guerra più terribile degli Stati Uniti, quella di secessione, fu combattuta per preservare l’unità del paese. In Europa l’unificazione ha offerto spesso il pretesto a un grande Stato di annettersi uno più piccolo: «Sicché si arriva al paradosso che quasi tutte le guerre sono state combattute in nome dell’unità e della pace, il che significa che, se non fossimo stati unionisti e pacifisti tanto accaniti, avremmo potuto evitare un buon numero di conflitti» (p. 123).
Il metodo per ridurre l’aggressività delle società umane è dunque quello, esattamente opposto, della divisione delle unità politiche troppo grandi. La Svizzera, ad esempio, ha sempre risolto pacificamente i propri dissidi interni con il metodo della separazione, suddividendo ulteriormente un cantone. Anche l’Europa dovrebbe prendere questo esempio, smembrando gli Stati nazionali in una moltitudine di piccole patrie corrispondenti alle attuali regioni o province. Eliminando le strutture artificiali delle grandi potenze, la carta d’Europa tornerebbe alla sua naturale conformazione. Secoli di convivenza forzata e di propaganda patriottica non hanno potuto infatti sradicare i sentimenti localistici e lo spirito di autonomia.
Ma non si verrebbe in questo modo a creare un mondo simile a quello medievale, durante il quale le piccole entità politiche combattevano tra loro senza sosta? In realtà le “guerre” che nel Medio Evo divampavano in ogni angolo d’Europa erano dei piccoli conflitti localizzati che duravano pochi giorni, e che spesso si concludevano senza vittime. Avevano conseguenze trascurabili perché le entità che le combattevano erano piccole e dotate di modeste risorse. A seguito delle unificazioni nazionali le guerre si verificano a intervalli più lunghi rispetto alle guerre medievali, ma hanno conseguenze molto più serie. Si hanno più prolungati periodi di pace, ma quando alla fine esplodono le guerre trascinano nel loro vortice una gran parte del mondo. Un solo mese di guerra moderna tra grandi potenze costa più, in vite umane e in beni, di quanto potessero costare secoli e secoli di guerre medioevali.
La libertà nei piccoli Stati
In un piccolo Stato gli individui sono più liberi perché non sentono soggezione nei confronti di chi governa e non possono essere sopraffatti dal potere. I governanti di un piccolo Stato sono, per così dire, i vicini di casa del cittadino. Tutti li conoscono personalmente, e perciò non potranno mai celarsi sotto quelle spoglie misteriose che permettono di assumere l’aria distaccata e severa di superuomini. I più grandi tiranni del mondo, come Cesare, Napoleone, Hitler o Stalin, sono sorti in grandi Stati, mentre in un piccolo Stato un dittatore sembra un ridicolo personaggio da operetta, e non fa paura a nessuno.
Anche la rappresentanza politica perde significato in un grande Stato, dove i cittadini rappresentano una parte infinitesimale della sovranità. Infatti, più l’aggregato sociale aumenta di proporzioni, più l’uomo diventa insignificante. In uno Stato vasto e popoloso l’individuo non ha alcuna possibilità di opporsi alla straripante potenza di un movimento di massa che, alla fine, è destinato a travolgerlo. Egli assorbirà la fede collettiva del grande gruppo organizzato, come il militarismo, il nazionalismo, il socialismo o il comunismo, e perderà la coscienza in un autonomo significato della sua vita.
Dove nasce il progresso culturale
I grandi Stati impressionano solo per la loro potenza materiale, e vengono ammirati in un mondo che stima più la forza fisica che i valori intellettuali. Lo spirito individuale, infatti, può affinarsi soltanto quando vive nel tranquillo e libero rifugio della piccola società, al riparo dalle grandi masse. Perciò non si deve attribuire a pura coincidenza il fatto che la cultura mondiale si sia sviluppata soprattutto in piccoli Stati. Tutti i grandi imperi dell’antichità non sono stati capaci, nei millenni della loro esistenza, di produrre dal punto di vista culturale nemmeno una minima parte di quello che è stato prodotto in alcuni decenni dalle piccole città-stato della Grecia.
Quando l’Italia era divisa in tante piccole entità politiche diede al mondo uomini come Dante, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Tasso e centinaia di altri, il meno importante dei quali sembra più grande del più notevole artista dell’Italia moderna, chiunque possa essere. Anche la Germania divisa in tantissime piccole corti reali produsse geni come Goethe, Wagner, Kant, Dürer, Holbein, Beethoven, Bach e centinaia di altri. Che cosa ci hanno dato le stesse regioni una volta divenute grandi potenze? Sono passate da raffinate forme di civiltà a un barbaro spirito di aggressione, producendo una masnada di uomini politici e militari senza immaginazione, come Hitler o Mussolini.
Vi sono ragioni precise per cui l’arte non può fiorire nell’aria irrespirabile delle grandi potenze. Innanzitutto i governanti dei piccoli Stati, non avendo eserciti potenti, possono sfogare la propria ambizione nei più pacifici campi dell’arte e della cultura. In Italia e in Germania il mecenatismo fu infatti il risultato della forte rivalità esistente tra la miriade di corti e principati. Ogni impresa artistica realizzata da uno di essi suscitava negli altri un fiero sentimento di gelosia e quindi nuovi tentativi di emulazione, generando una creazione artistica senza soste.
Grazie a questo processo oggi noi possiamo ammirare una sorprendente varietà di tendenze artistiche e architettoniche, ben diverse dalla monotonia e dallo scialbore delle gigantesche opere dovute ai ciclopici organismi politici successivi. Se in parecchi Stati europei di grande estensione, come l’Italia, la Francia o la Germania, è ancora possibile, con viaggi relativamente brevi, fare esperienza di tante interessanti differenze culturali, ciò è dovuto al fatto che il pluralismo politico medievale ha lasciato un’impronta così duratura che neppure il processo di unificazione ha potuto cancellarla. Oggi, osserva Kohr, i turisti accorrono per godersi le bellezze create non dagli Stati nazionali ma dai loro piccoli e “arretrati” predecessori.
Inoltre, grazie alla limitata importanza che hanno i problemi sociali nei piccoli Stati, i cittadini si trovano nelle condizioni migliori per coltivare l’arte e la cultura. Le grandi creazione della mente umana, infatti, non sono favorite dalla partecipazione alla vita politica, ma al contrario si giovano dall’allontanamento da essa. Nei piccoli Stati non c’è bisogno di enormi apparati di governo e di controllo, per cui la maggior parte dei cittadini può dedicarsi al miglioramento dell’individuo anziché al servizio dello Stato. Le esigenze sociali delle grandi potenze, al contrario, sono tali da assorbire tutte le energie disponibili non solo dei funzionari di Stato, ma anche dei cittadini. Negli Stati nazionali gli artisti, i poeti, i letterati e i musicisti sono progressivamente sostituiti da specialisti, tecnici, organizzatori ed esperti di problemi sociali.
Grandi Stati, grandi problemi
In un mondo di grandi Stati, osserva Kohr, siamo continuamente assillati da giganteschi problemi sui quali non abbiamo nessuna possibilità di influire e che ci rovinano la vita. In un mondo come il nostro “ogni dannata questione è diventata un problema per tutti”. In un sistema di piccoli Stati, invece, le numerose frontiere fanno da elementi isolanti, e i problemi delle regioni lontane restano problemi remoti. Invece di doverci occupare di calamità universali, permanenti e impersonali, ci ritroviamo in una realtà ristretta in cui siamo protagonisti. In questo piccolo ambiente tutto fa parte della nostra esperienza personale, e i problemi non avranno carattere anonimo, ma ci toccheranno da vicino. Non esiste grave problema sulla terra che non possa essere felicemente risolto su scala ridotta, mentre su vasta scala tutti i problemi diventano incomprensibili e spaventosi, dato che non esiste intelligenza umana capace di gestirli.
Contrastando la mania suicida delle unificazioni politiche nazionali o sovranazionali, Kohr propone di smembrare tutte le attuali grandi potenze all’interno di federazioni composte da tante unità di grandezza simile. Ad esempio, si potrebbe creare un Consiglio Europeo senza Stati nazionali, in cui ogni provincia della Francia, della Germania, dell’Inghilterra, dell’Italia, della Spagna e di tutti gli altri paesi abbia diritto a un voto. In questo modo le attuali nazioni più grandi conserverebbero un maggior numero di voti. “Ma sarà fatto?”. La risposta si trova nel brevissimo undicesimo capitolo, che è composto da una sola parola: No!
Anche se l’autore non si illude sulla disponibilità delle grandi nazioni a farsi polverizzare, egli è tuttavia persuaso che tutti i potenti Stati e imperi sono prima o poi destinati a crollare sotto il proprio peso. La storia, scrive Kohr, si ripeterà, e le epoche di sterilità intellettuale segnate dal dominio delle grandi potenze lasceranno il posto alla grandezza culturale che ha caratterizzato i mondi piccoli e liberi del passato, come quelli del Medio Evo o dell’Antica Grecia.
Citazioni rilevanti
La causa della guerra
«E anche in questo caso vedremo come la causa di un terribile evento come la guerra non debba essere attribuita a diabolici disegni o a perfide inclinazioni, ma all’esistenza di un potere eccessivo in mano a società troppo vaste. Il fatto è che ogniqualvolta uno Stato diventa grande abbastanza per accumulare la massa critica di potere, prima o poi cederà alla tentazione. E appena tale potere sarà nelle sue mani, diventerà uno Stato aggressore, nonostante il suo passato e le buone intenzioni» (p. 80).
I grandi Stati sono totalitari per natura
«Per quale motivo gli uomini non dovrebbero avere tanti sistemi quanti essi ne desiderano, invece di dover adattarsi tutti allo stesso quando la metà non lo considera di proprio gusto? Se la libertà di scelta è considerata un vantaggio dal punto di vista economico, perché non dovrebbe esserlo dal punto di vista politico?» (p. 145)
I cattivi maestri centralisti
«Non riuscendo a sottrarsi al fascino di un grande potere, il quale, pur essendo contro ogni regola di buon senso, esercita una forte attrattiva psicologica, essi scagliano i loro feroci strali contro tutto ciò che è piccolo, innalzando all’onore degli altari tutto ciò che rappresenta grandezza, volume, massa. Essi ci hanno persuaso a venerare il colossale e poi si sono stupiti che noi ci inchinassimo a Hitler che impersonava proprio questo ideale di grandezza» (p. 218-219).
Le degenerazione culturale di italiani e tedeschi
«Fin dal loro sorgere come grande potenza nel 1871, gli Italiani, nel complesso, non hanno più desiderato di farsi conoscere come artisti ma come padroni, non come pacifici agnellini, ma come conquistatori, non come Fiorentini ma come Romani. Il potere li ha trasformati in Prussiani, come è avvenuto dei Prussiani stessi, e il passo romano, che Mussolini non a caso introdusse nel suo esercito, corrisponde esattamente alla mentalità che si era venuta creando in Italia dopo il 1871, come è vero che la gentilezza, la sensibilità artistica, la grazia e la delicatezza non erano affatto estranei alla mentalità tedesca prima di tale data, cioè quando la Germania era ancora in gran parte divisa in un complesso di piccoli Stati» (p. 249).
Gli inevitabili sperperi delle grandi potenze
«Più una società diventa potente, più aumenta la parte della sua produzione che, invece di accrescere i consumi individuali, viene assorbita dalla necessità di risolvere i problemi causati dal sorgere del suo grande potere … Esempi della prima categoria di questi beni “di sviluppo” che elevano il livello della società senza aggiungere nella al benessere materiale dei suoi membri, sono quelli che potrebbero essere chiamati i vantaggi del potere, come i carri armati, le bombe, o il perfezionamento dei servizi pubblici necessari per amministrare un’accresciuta potenza» (p. 281).
I fanatici delle unificazioni
«In Europa i sentimenti particolaristici, malgrado siano stati per lungo tempo soffocati dai grandi Stati unitari e sottoposti all’incessante martellamento di una propaganda a favore dell’unificazione, ancora esistono conservando immutato il loro vigore, e ben poche delle piccole e numerose nazioni d’Europa, ora unite insieme nell’ambito di grandi potenze, potrebbero essere lasciate in libertà per una sola settimana senza correre il rischio di vederle subito all’opera per rivendicare una propria sovranità, e un parlamento e una capitale propria. Naturalmente esistono individui – come i maestri elementari, i nazionalisti, i militari, i collettivisti, i maniaci dell’umanità, ed altri che in costruzioni unitarie trovano un motivo di esaltazione, i quali tutti, con cieco fanatismo e con reazionaria violenza, si oppongono al concetto dei piccoli Stati democratici» (p. 368-369).
L’autore
Leopold Kohr (1909-1994) nasce nella piccola città di Oberndorf bei Salzberg, in Austria, che rimane per sempre nella sua mente come il tipo ideale di comunità. Consegue il dottorato in legge presso l’Università di Innsbruck e in Scienze politiche presso l’Università di Vienna. Studia poi economia e teoria politica presso la London School of Economics. Nel 1937, durante la guerra civile spagnola, diviene corrispondente free-lance, e rimane profondamente colpito dagli esperimenti anarchici nelle città di Alcoy e di Caspe. In quel periodo diventa amico e si trova a lavorare con George Orwell, Ernest Hemingway, André Malraux. Nel 1938, fugge dall’Austria dopo l’annessione alla Germania nazista, ed emigra negli Stati Uniti dove prende la cittadinanza. Dal 1943 al 1955 Kohr insegna economia e filosofia politica nel New Jersey presso la Rutgers University, mentre dal 1955 al 1973 insegna Economia e della Pubblica amministrazione presso l’Università di Puerto Rico. Dopo molti rifiuti ricevuti, da parte di editori americani e inglesi, nel 1957 riesce a pubblicare in Gran Bretagna The Breakdown of Nations, grazie all’aiuto dell’anarchico britannico Herbert Read. Nel 1973 si trasferisce nel Galles, e svolge attività di sostegno al movimento di indipendenza gallese. Qui insegna filosofia politica presso l’Aberystwyth University. Dopo il ritiro dall’attività didattica Kohr divise il suo tempo tra Gloucester e Hellbrunn, nei pressi di Salisburgo. Muore a Gloucester il 26 febbraio 1994, e viene sepolto nel suo paese natale di Oberndorf.